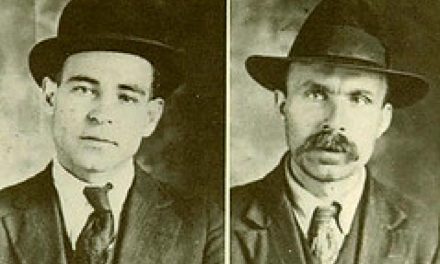Il fenomeno migratorio italiano è complesso e composto da mille diverse varianti. L’unica cosa in comune fra i nostri bisnonni e nonni, provenienti da svariate regioni italiane, era cercare una alternativa di vita, scappare dalla fame e dalla mancanza assoluta di una vita dignitosa, ma verso che? Dove? La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, partì nei decenni successivi all’Unità di Italia, durante la cosiddetta “grande emigrazione” (1876-1915). Si calcola che dopo l’Unità d’Italia e per circa un secolo, diciamo anni 70, siano partiti quasi 30 milioni di emigranti. Mete ricercate erano l’America, Stati Uniti e anche America Latina, Australia, e alcuni paesi del nord Europa, quali Svizzera, Francia, Belgio, Germania.

Imbarco di emigranti al Porto di Genova, con destinazione Brasile nel 1898-Foto pubblico dominio da commons.wikimedia.org
Questa immensa fuga diventa un osservatorio particolare per valutare l’intreccio, spesso drammatico, tra il progetto migratorio in quanto tale, che riguarda obiettivamente popolazioni di estrazione subalterna e le meccaniche dello sfruttamento nei loro confronti. Per non parlare poi dei drammatici viaggi di ritorno, dove per tantissimi di loro era tutto finito, tutto perduto quel sogno e quella speranza vanificata, passando da provvedimenti di rimpatrio coatto, in quanto malati o considerati mentalmente malati, oltre quelli che nel viaggio di andata, in condizioni terribili si erano a loro volta ammalati o peggio morti. Dimenticati e soli, spesso avevano venduto, male, quel poco che avevano ed erano partiti, col treno, ma spesso più con navi a vapore verso paesi che reclamavano forza umana, senza sapere dove sarebbero andati, come li avrebbero accolti, sapevano solo che c’era del lavoro da fare, spesso non sapevano nemmeno quale…lavorare la terra, scendere in miniera….Quello che succede sulle navi è marginale rispetto al fine da raggiungere, ammassati, senza cibo, senza potersi lavare e solo guardare dagli oblò il mare, magari mosso, che schiaffeggia la fiancata ma anche i loro visi e cuori. L’attesa di un destino di vita diverso fa accettare tutto, per raggiungere una meta. Si aggiungano le avversità o gli inconvenienti dovuti a visite mediche approssimative non superate, frodi da parte degli agenti di emigrazione, la nave sulla quale imbarcarsi non c’è, chi è derubato delle sue povere cose, le valigie di cartone con lo spago di buona memoria, nel viaggio o nel porto, la nave talmente vecchia e malandata che non arriva nemmeno a destinazione.
Di queste memorie si ha traccia solo, non sempre, a posteriori, racconti a distanza di anni, in caso di un ritorno in terra natia, una lettera magari fatta scrivere da uno meno analfabeta del gruppo e spedita con un indirizzo finale descritto a parole, magari in dialetto, milioni di situazioni di cui non resta traccia o minimale. Di questo esodo lunghissimo chi ne scrive magari è uno studioso, un appartenente a quella classe sociale più elevata che ha messo in movimento questa classe di basso livello, e poi, ma sì, è anche un modo per separarsi da contadini poveri, ignoranti, qualche artigiano o operaio non formato, una maniera per “pulire” l’Italia di soggetti potenzialmente pericolosi o comunque non produttivi secondo le necessità dei proprietari. Spesso poi il dolore maggiore era dato dal fatto che una volta sbarcati il viaggio non era finito, anzi cominciava per raggiungere la destinazione finale, che spesso era solo un nome, forse compreso anche male. Pensiamo all’America Latina, dopo un viaggio di venti giorni in mare magari occorreva un mese per raggiungere la destinazione, tra valli e paludi, montagne e pianure sconfinate.
E’ di pochi mesi fa l’inaugurazione del MEI, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, proprio a Genova l’11 maggio scorso, in cui in numerose sale vengono rappresentate e ricordate le più antiche migrazioni della storia, ovviamente incluse le più recenti che riguardano l’Italia (per questo rimando a un articolo del collega Paolo Piccinni, da poco pubblicato sul nostro sito).

Foto pubblico dominio da wikipedia.org
E così nel 1925 Mario Cappello, (Genova, 1895 – 1954), un genovese che era un cultore della “genovesità”, amante dei versi e ottimo conoscitore della realtà della città e del suo porto, scrisse la canzone “Ma se ghe pensu”, in poco divenne l’inno di Genova, dei migranti, ripresa e divulgata da vari cantautori genovesi, di quella che poi diventerà la scuola genovese, anche da Gino Paoli, Mina nel 1967 e Gilberto Govi. Il brano è la storia di un genovese emigrato in America Latina in cerca di una vita migliore, fine 800, che ogni tanto ripensa alla sua città, la nostalgia e i ricordi lo struggono nel cuore, vuole così fare ritorno, anche fosse solo per morire, col figlio che cerca di dissuaderlo, trovandosi lui invece bene nella nuova città, dove poi è nato. L’autore del brano fa raccontare al vecchio che era partito senza soldi, solo con una speranza in tasca, ora finalmente si è realizzato, anche economicamente, con tanti sacrifici e risparmi, da buon genovese, ora vuole solo tornare alla sua terra, al suo nido lo definisce. Questa canzone in poco diventa la rappresentazione di Genova, rappresenta l’attaccamento dei genovesi alla propria città e i ricordi, la nostalgia sono più forti di tutto.
E allora cantiamola, forse meglio quasi sussurrata, in dialetto genovese e con testo a fronte:
| «O l’êa partîo sénsa ‘na palanca, l’êa za trent’anni, fòrse anche ciù. O l’àia lotòu pe métte i dinæ a-a bànca e poéisene un giórno vegnî in zu. E fâse a palassinn-a e o giardinétto, co-o ranpicante, co-a cantinn-a e o vin, a branda attacâ a-i èrboi, a ûso letto, pe dâghe ‘na schenâ seja e matìn. Ma o figgio o ghe dixeiva: “No ghe pensâ a Zena cöse ti ghe vêu tornâ?!” Ma se ghe penso alôa mi veddo o mâ, véddo i mæ mónti e a ciàssa da Nonçiâ, rivéddo o Righi e me s’astrenze o cheu, véddo a Lanterna, a Cava, lazù o Meu… Rivéddo a-a seja Zêna ilûminâ, véddo la-a Fôxe e sento franze o mâ e alôa mi pénso ancón de ritornâ a pösâ e òsse dôve ò mæ madonâ. O l’êa passòu do ténpo, fòrse tròppo, o figgio o l’inscisteiva: “Stémmo ben, dôve t’êu andâ, papà?.. pensiêmo dòppo, o viâgio, o mâ, t’ê vêgio, no convén!” “Òh no, òh no! mi me sento ancón in ganba, son stùffo e no ne pòsso pròpio ciù, L’è in pö che sento dî: señor, caramba, mi vêuggio ritornâmene ancón in zû… Ti t’ê nasciûo e t’æ parlòu spagnòllo, mi son nasciûo zeneize e… no me mòllo!” Ma se ghe penso alôa mi véddo o mâ, véddo i mæ mónti e a ciàssa da Nonçiâ, rivéddo o Righi e me s’astrenze o cheu, véddo a Lanterna, a Cava, lazù o Meu… Rivéddo a-a seja Zêna iluminâ, véddo la-a Fôxe e sénto franze o mâ e alôa mi pénso ancón de ritornâ a pösâ e òsse dôve ò mæ madonâ. E sénsa tante cöse o l’é partîo e a Zêna o gh’à formòu tórna o seu nîo.» |
«Era partito senza un soldo, aveva già trent’anni, forse anche più. Aveva lottato per mettere i soldi in banca e potersene un giorno tornare ancora giù e farsi la palazzina e il giardinetto, con il rampicante, con la cantina e il vino, la branda attaccata agli alberi a uso letto, per coricarcisi alla sera e al mattino. Ma il figlio gli diceva: “Non ci pensare a Genova perché ci vuoi tornare?!” Ma se ci penso allora io vedo il mare, vedo i miei monti e piazza della Nunziata, rivedo il Righi e mi si stringe il cuore, vedo la Lanterna, la cava, laggiù il molo… Rivedo alla sera Genova illuminata, vedo là la Foce e sento frangere il mare e allora io penso ancora di ritornare a posare le ossa dove è mia nonna. Ed era passato del tempo, forse troppo, il figlio insisteva: “Stiamo bene, dove vuoi andare, papà?..penseremo dopo; il viaggio, il mare, sei vecchio, non conviene!” “Oh no, oh no! mi sento ancora in gamba, sono stanco e non ne posso proprio più, sono stufo di sentire: señor, carramba, io voglio ritornarmene ancora in giù… Tu sei nato e hai parlato spagnolo, io sono nato genovese e… non ci mollo!” Ma se ci penso allora io vedo il mare, vedo i miei monti e piazza della Nunziata, rivedo Righi e mi si stringe il cuore, vedo la Lanterna, la cava, laggiù il molo… Rivedo la sera Genova illuminata, vedo là la Foce e sento frangere il mare, e allora io penso ancora di ritornare a posare le ossa dove è mia nonna. E senza tanti indugi è partito e a Genova ha formato di nuovo il suo nido.» |
Imbarco di Emigranti dal porto di Genova – Foto pubblico dominio da commons.wikimedia.org